Presentazione
Settimana di Studi 2026
Scheda di
partecipazione 2026
Settimana di Studi 2025
Norme editoriali
Temi 1969-2027
Settimana di Studi 2026
Scheda di
partecipazione 2026
Settimana di Studi 2025
Norme editoriali
Temi 1969-2027
CALL FOR RESEARCH PAPERS 2025-2027
LVIII SETTIMANA DI STUDI:
Call for research papers 2025-2027
scarica la Call 2025-2027
Format
per l'invio
delle proposte
• • •
CALL FOR PAPERS DATINI-ESTER ADVANCED SEMINAR 2026:
DATINI-ESTER
CALL 2026
FORM PER LA CANDIDATURA AL:
ADVANCED SEMINAR DATINI-ESTER 2026
LVIII SETTIMANA DI STUDI:
Call for research papers 2025-2027
scarica la Call 2025-2027
Format
per l'invio
delle proposte
• • •
CALL FOR PAPERS DATINI-ESTER ADVANCED SEMINAR 2026:
DATINI-ESTER
CALL 2026
FORM PER LA CANDIDATURA AL:
ADVANCED SEMINAR DATINI-ESTER 2026
LV Settimana di Studi
La mobilità sociale nelle società preindustriali: tendenze, cause ed effetti (secc. XIII-XVIII) • Social Mobility in pre-industrial societies: tendencies, causes and effects (13th-18th centuries)
La mobilità sociale nelle società preindustriali: tendenze, cause ed effetti (secc. XIII-XVIII) • Social Mobility in pre-industrial societies: tendencies, causes and effects (13th-18th centuries)
Prato, 12-16 maggio 2024
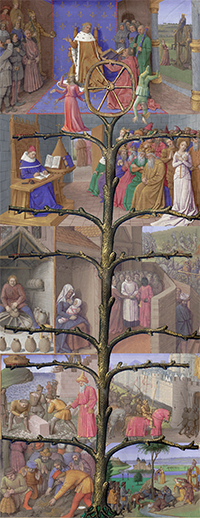
Particolari tratti da Boccaccio, Giovanni: Le livre de Jehan Bocace des cas des nobles hommes et femmes - BSB (© München, Bayerische Staatsbibliothek) Cod.gall. 6, 1458
PROGRAMMA
Domenica 12 maggio
17.30, Sala Maggiore del Palazzo Comunale
[Cerca sulla mappa]
• APERTURA DEI LAVORI:
Saluti
• Prolusione
Guido Alfani (Università Bocconi, Milano)
Saluti
• Prolusione
Guido Alfani (Università Bocconi, Milano)
Lunedì 13 maggio
Ridotto - Teatro Politeama Pratese
[Cerca la sede del convegno]09.00-13.00
I – FONTI E METODI/SOURCES AND METHODS
Francesco Ammannati (Università di Firenze), Misurare la mobilità sociale in Toscana tra Medio Evo ed Età Moderna
Benedetta Crivelli (Università di Parma), La mobilità occupazione a Verona tra tardo medioevo ed età moderna: fonti e questioni metodologiche
Matteo Di Tullio (Università di Pavia), La mobilità sociale a Bergamo e nel bergamasco tra tardo medioevo ed età moderna: fonti e metodi d'indagine
Luciano Maffi (Università di Parma), La mobilità sociale nel Basso Piemonte durante la prima età moderna. Gli estimi del territorio di Tortona: fonti e metodi d'indagine
Mattia Viale (Università di Padova), Gli estimi della Repubblica di Venezia come fonte per lo studio della mobilità sociale nelle aree rurali in età preindustriale
Benedetta Crivelli (Università di Parma), La mobilità occupazione a Verona tra tardo medioevo ed età moderna: fonti e questioni metodologiche
Matteo Di Tullio (Università di Pavia), La mobilità sociale a Bergamo e nel bergamasco tra tardo medioevo ed età moderna: fonti e metodi d'indagine
Luciano Maffi (Università di Parma), La mobilità sociale nel Basso Piemonte durante la prima età moderna. Gli estimi del territorio di Tortona: fonti e metodi d'indagine
Mattia Viale (Università di Padova), Gli estimi della Repubblica di Venezia come fonte per lo studio della mobilità sociale nelle aree rurali in età preindustriale
Ridotto - Teatro Politeama Pratese
[Cerca la sede del convegno]15.00-18.00
I – FONTI E METODI/SOURCES AND METHODS
Albert Reixach Sala, Pau Viciano (Universidad de Lleida, Universidad de València), Social mobility in the towns and countryside of Late Medieval Crown of Aragon (c.1300-c. 1550): detecting parameters and patterns from a wide range of archives
II - MOBILITÀ SOCIALE, CRESCITA ECONOMICA E DISUGUAGLIANZA ECONOMICA/SOCIAL MOBILITY, ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC INEQUALITY
Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Maas (Utrecht University), Social mobility in the eighteenth and early nineteenth centuries
Jan Michael Goldberg (Martin Luther University Halle-Wittenberg), Transformation of urban occupational structure and occupational mobility (Leipzig, 1550-1850)
José Antonio Mateos Royo (Universidad de Zaragoza), Peaceful conquest or skillful adaptation? The rise of Genoese merchants in Aragon (1580-1620)
Jan Michael Goldberg (Martin Luther University Halle-Wittenberg), Transformation of urban occupational structure and occupational mobility (Leipzig, 1550-1850)
José Antonio Mateos Royo (Universidad de Zaragoza), Peaceful conquest or skillful adaptation? The rise of Genoese merchants in Aragon (1580-1620)
• 18.00 - Riunione del Comitato Scientifico
Martedì, 14 maggio
Ridotto - Teatro Politeama Pratese
[Cerca la sede del convegno]09.00-13.00
II - MOBILITÀ SOCIALE, CRESCITA ECONOMICA E DISUGUAGLIANZA ECONOMICA/SOCIAL MOBILITY, ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC INEQUALITY
David Carvajal De La Vega, Hilario Casado Alonso (Universidad de Valladolid), Vanesa Abarca Abarca (Universidad de Salamanca), Economic inequality, social mobility and political tensions in Castile (fifteenth and sixteenth centuries)
Mikolaj Malinowski (Groningen University), Incredible commitment: Influence accumulation, consensus-making, and the collapse of the Polish-Lithuanian Commonwealth
Maïka De Keyzer, Alberto Concina, Jan Peeters (KU Leuven), Economic growth and prosperity: Two sides of the same coin? A comparison of the countryside of Antwerp and Piedmont in the long eighteenth century
Mikolaj Malinowski (Groningen University), Incredible commitment: Influence accumulation, consensus-making, and the collapse of the Polish-Lithuanian Commonwealth
Maïka De Keyzer, Alberto Concina, Jan Peeters (KU Leuven), Economic growth and prosperity: Two sides of the same coin? A comparison of the countryside of Antwerp and Piedmont in the long eighteenth century
Ridotto - Teatro Politeama Pratese
[Cerca la sede del convegno]15.00-18.00
II - MOBILITÀ SOCIALE, CRESCITA ECONOMICA E DISUGUAGLIANZA ECONOMICA/SOCIAL MOBILITY, ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC INEQUALITY
Wouter Ronsijn, Wouter Ryckbosch (Ghent University, Vrije Univ. Brussel), Income and wealth mobility in the smaller towns of the late medieval and early modern Low Countries: an exploratory analysis
Sonia Schifano (Università Bocconi Milano), Ferreira Flores Tiago, Paccoud Antoine (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research - Esch-sur-Alzette), Inequality in pre-industrial Luxembourg (1766-1842): comparing the effects of the end of feudalism in rural and urban areas
Neil Cummins (London School of Economics), On Using Wills to Infer Wealth Inequality and Intergenerational Social Mobility, England 1500-1800
Sonia Schifano (Università Bocconi Milano), Ferreira Flores Tiago, Paccoud Antoine (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research - Esch-sur-Alzette), Inequality in pre-industrial Luxembourg (1766-1842): comparing the effects of the end of feudalism in rural and urban areas
Neil Cummins (London School of Economics), On Using Wills to Infer Wealth Inequality and Intergenerational Social Mobility, England 1500-1800
• 18.00 - Riunione della "Giunta" del Comitato scientifico
Mercoledì, 15 maggio
Ridotto - Teatro Politeama Pratese
[Cerca la sede del convegno]09.00-13.00
III – MOBILITÀ SOCIALE, MOBILITÀ GEOGRAFICA E DINAMICHE DEMOGRAFICHE/SOCIAL MOBILITY, GEOGRAPHIC MOBILITY AND DEMOGRAPHIC DYNAMICS
Antoni Furió Diego, Carlos Laliena Corbera, Pere Verdés Pijuan (Univ. de València, Univ. de Zaragoza, CSIC-IMF), Social mobility, economic growth and inequality in the late medieval Crown of Aragon (Aragon, Catalonia, Valencia and Mallorca, 13th-15th centuries)
Gabriel Brea-Martínez, Joana-Maria Pujadas-Mora (Lund University, Open Univ. of Catalonia), Socioeconomic mobility and inequality persistence. The area of Barcelona, 16th-19th centuries
Hannelore Pepke (Université de Bourgogne), La mobilité sociale dans le vignoble bourguignon à la fin du Moyen Age, entre stratégies individuelles et reconnaissance collective
Mattia Fochesato, Francesco Bettarini (Università Bocconi Milano), The impact of political and economic change on the occupational structure in Renaissance Florence. A preliminary investigation
Gabriel Brea-Martínez, Joana-Maria Pujadas-Mora (Lund University, Open Univ. of Catalonia), Socioeconomic mobility and inequality persistence. The area of Barcelona, 16th-19th centuries
Hannelore Pepke (Université de Bourgogne), La mobilité sociale dans le vignoble bourguignon à la fin du Moyen Age, entre stratégies individuelles et reconnaissance collective
Mattia Fochesato, Francesco Bettarini (Università Bocconi Milano), The impact of political and economic change on the occupational structure in Renaissance Florence. A preliminary investigation
Ridotto - Teatro Politeama Pratese
[Cerca la sede del convegno]15.00-18.00
IV – INTERAZIONI TRA LA MOBILITÀ SOCIALE E L'EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE FAMILIARI E DEI SISTEMI EREDITARI/INTERACTION BETWEEN SOCIAL MOBILITY AND THE EVOLUTION OF FAMILY STRUCTURES AND INHERITANCE SYSTEMS
Gabriel Ramon-Molins (Universidad de Lleida-Universidad de Girona), Prosperare a credito, rovinarsi con i debiti: l'indebitamento come catalizzatore della mobilità sociale nel nord della Catalogna (1785-1800)
Aristea Gratsea (University of Crete), Marriage alliances and socio-economic mobility in Venetian Crete (16th century)
Aristea Gratsea (University of Crete), Marriage alliances and socio-economic mobility in Venetian Crete (16th century)
Giovedì, 16 maggio
Ridotto - Teatro Politeama Pratese
[Cerca la sede del convegno]09.00-13.00
IV – INTERAZIONI TRA LA MOBILITÀ SOCIALE E L'EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE FAMILIARI E DEI SISTEMI EREDITARI/INTERACTION BETWEEN SOCIAL MOBILITY AND THE EVOLUTION OF FAMILY STRUCTURES AND INHERITANCE SYSTEMS
Mas Ferrer Josep (University of Girona), Female social mobility in an impartible inheritance society at the end of the pre-industrial era (north-eastern Catalonia, 1750-1825)
Javier Castaño (Spanish National Research Council, Madrid), Social Mobility and Family Structure within Hispano-Jewish Society
Sabrina Corbellini (University of Groningen), Reading and Writing for Success: literacy, knowledge and social mobility
Javier Castaño (Spanish National Research Council, Madrid), Social Mobility and Family Structure within Hispano-Jewish Society
Sabrina Corbellini (University of Groningen), Reading and Writing for Success: literacy, knowledge and social mobility
Ridotto - Teatro Politeama Pratese
[Cerca la sede del convegno]15.00-18.00
CONCLUSIONI – Tavola rotonda
Franco Franceschi
Guido Alfani
Wouter Ryckbosch
Antoni Furió
Guido Alfani
Wouter Ryckbosch
Antoni Furió