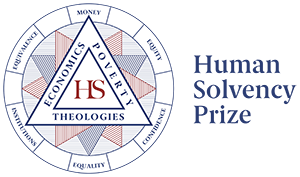
“Human Solvency Historical Research Prize 2024”
realizzato / created
in collaborazione con / with the contribution of:


con il contributo di / with the contribution of:
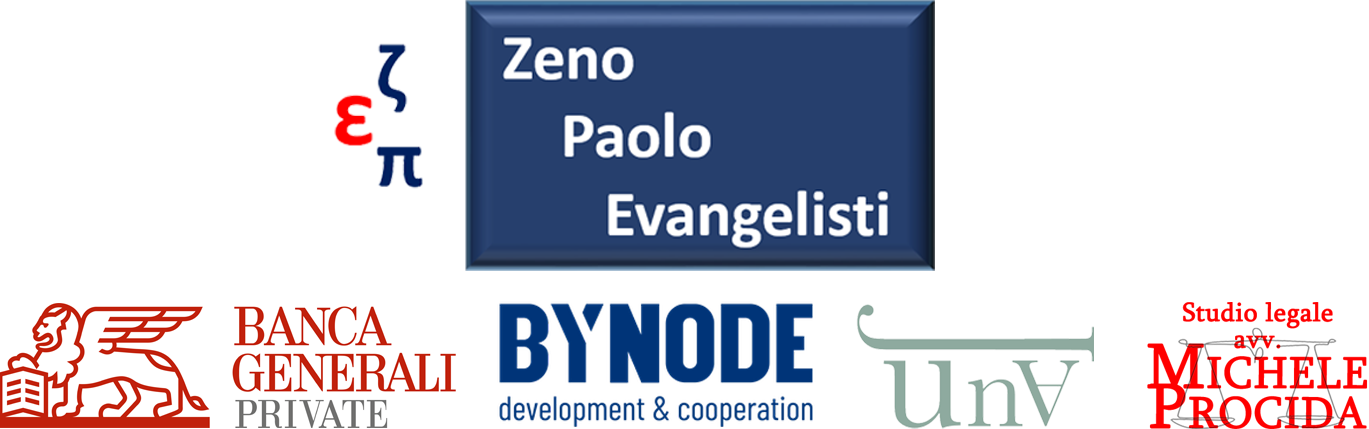

Il dr Luca Ughetti, vincitore della I edizione del Premio / Dr Luca Ughetti, winner of the 1st edition of the Prize.
“Human Solvency Historical Research Prize 2024”
VINCITORE/WINNER: dr. Luca Ughetti
Retorica e mercatura.
La formazione del linguaggio economico nella predicazione dellĺOsservanza francescana
Tesi di laurea congiunta tra Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, UniversitÓ di Firenze e UniversitÓ di Siena, Dottorato di ricerca in Studi Storici (XXXIV ciclo) e Formation doctorale Histoire et Civilisation (ED 286). Disciplina: Storia Medievale - Supervisione: Mathieu Arnoux e Franco Franceschi, [pp. 360] [20 luglio 2022]
MOTIVAZIONE / REASON
Il merito della tesi del dr. Luca Ughetti consiste nell'aver condotto sul piano concreto delle fonti, nel tessuto scrittorio, organizzativo e multistratificato che le formano e le condizionano reciprocamente, l'analisi delle relazioni lessicali e concettuali che sono alla base del formarsi del linguaggio economico tardomedievale.
La messa a punto di una discorsivitÓ economica capace di illuminare figure, soggetti, azioni, contratti per descrivere ed accreditare un'immagine stabile e dunque persuasiva delle societÓ europee dello scambio affermatesi tra XIV e XVI secolo, trova in questo lavoro un punto di sviluppo, di ulteriore maturazione di una storiografia che ha ormai una tradizione consolidata, databile ad almeno sei decenni.
Il lavoro di Ughetti Ŕ stato riconosciuto dal Comitato scientifico del premio come il migliore tra quelli presentati in questa edizione avendo messo in dialogo proficuo saperi, tipologie testuali ma anche codificazioni concettuali che spesso restano ancora appannaggio di studio di singole discipline e partizioni cronologiche che riducono, in tal modo, lo spazio della loro comprensione storica.
L'analisi ravvicinata delle fonti omiletiche tre-quattrocentesche ľ perno centrale di questo lavoro - ha dimostrato la loro qualitÓ peculiare: quella di essere un materiale intrinsecamente performativo, costantemente situato socialmente, capace di individuare e definire di volta in volta il suo referente civico ed economico. Essa Ŕ stata condotta con profonda consapevolezza e attenzione alle diverse dimensioni della ricerca storica: da quella filologica alla piena valorizzazione euristica. In questo quadro l'incrocio fecondo dell'analisi condotta sui dizionari ed i linguaggi scritturistici, teologici, economici e giuridici, compresi quelli codificanti normative di governo di mercati locali, ha consentito di dare profonditÓ e larghezza di orizzonte alla ricerca proposta, mettendo in luce le interazioni con un lessico cristiano di lunga durata. Va qui segnalato uno dei risultati pi¨ significativi di questo lavoro: la ricostruzione puntuale dell'appropriazione bernardiniana dell'esegesi dell'Apocalisse, delle sue risorse linguistiche. Scollata dal suo orizzonte tradizionalmente escatologico e millenaristico essa viene declinata dall'Albizzeschi in chiave interamente economica, agendo proprio sulla dilatazione semantica e semiotica di lessemi e figure chiave del testo.
Come ricorda lo stesso studioso ognuno dei capitoli della tesi dottorale si propone anche come caso di studio, offrendosi cosý come risorsa e base metodologica per ulteriori, quanto evidenti e proficue, prospettive di ricerca.
Dal punto di vista della storia economica questo lavoro ha il merito di aver mostrato come l'omiletica mendicante pensata, predicata, costantemente rimaneggiata, rappresentata e riportata nelle fonti coeve abbia rilevato l'emergere di figure professionali, di pratiche commerciali, di povertÓ e competitivitÓ salariali che venivano identificate e misurate nel loro impatto sociale e politico, contribuendo a costruire quella vasta gamma di dispositivi normativi sempre pi¨ necessari alle realtÓ politiche impegnate a rafforzare la loro soliditÓ attraverso modelli di accentramento e fidelizzazione crescenti. Si Ŕ in tal modo messo a fuoco come, con quali strumenti, nelle societÓ tardomedievali, segnatamente francesi ed italiane, la retorica pensata e veicolata dall'omiletica abbia costantemente reagito con il mobilissimo e dinamico spazio di azione della mercatura.
La messa a punto di una discorsivitÓ economica capace di illuminare figure, soggetti, azioni, contratti per descrivere ed accreditare un'immagine stabile e dunque persuasiva delle societÓ europee dello scambio affermatesi tra XIV e XVI secolo, trova in questo lavoro un punto di sviluppo, di ulteriore maturazione di una storiografia che ha ormai una tradizione consolidata, databile ad almeno sei decenni.
Il lavoro di Ughetti Ŕ stato riconosciuto dal Comitato scientifico del premio come il migliore tra quelli presentati in questa edizione avendo messo in dialogo proficuo saperi, tipologie testuali ma anche codificazioni concettuali che spesso restano ancora appannaggio di studio di singole discipline e partizioni cronologiche che riducono, in tal modo, lo spazio della loro comprensione storica.
L'analisi ravvicinata delle fonti omiletiche tre-quattrocentesche ľ perno centrale di questo lavoro - ha dimostrato la loro qualitÓ peculiare: quella di essere un materiale intrinsecamente performativo, costantemente situato socialmente, capace di individuare e definire di volta in volta il suo referente civico ed economico. Essa Ŕ stata condotta con profonda consapevolezza e attenzione alle diverse dimensioni della ricerca storica: da quella filologica alla piena valorizzazione euristica. In questo quadro l'incrocio fecondo dell'analisi condotta sui dizionari ed i linguaggi scritturistici, teologici, economici e giuridici, compresi quelli codificanti normative di governo di mercati locali, ha consentito di dare profonditÓ e larghezza di orizzonte alla ricerca proposta, mettendo in luce le interazioni con un lessico cristiano di lunga durata. Va qui segnalato uno dei risultati pi¨ significativi di questo lavoro: la ricostruzione puntuale dell'appropriazione bernardiniana dell'esegesi dell'Apocalisse, delle sue risorse linguistiche. Scollata dal suo orizzonte tradizionalmente escatologico e millenaristico essa viene declinata dall'Albizzeschi in chiave interamente economica, agendo proprio sulla dilatazione semantica e semiotica di lessemi e figure chiave del testo.
Come ricorda lo stesso studioso ognuno dei capitoli della tesi dottorale si propone anche come caso di studio, offrendosi cosý come risorsa e base metodologica per ulteriori, quanto evidenti e proficue, prospettive di ricerca.
Dal punto di vista della storia economica questo lavoro ha il merito di aver mostrato come l'omiletica mendicante pensata, predicata, costantemente rimaneggiata, rappresentata e riportata nelle fonti coeve abbia rilevato l'emergere di figure professionali, di pratiche commerciali, di povertÓ e competitivitÓ salariali che venivano identificate e misurate nel loro impatto sociale e politico, contribuendo a costruire quella vasta gamma di dispositivi normativi sempre pi¨ necessari alle realtÓ politiche impegnate a rafforzare la loro soliditÓ attraverso modelli di accentramento e fidelizzazione crescenti. Si Ŕ in tal modo messo a fuoco come, con quali strumenti, nelle societÓ tardomedievali, segnatamente francesi ed italiane, la retorica pensata e veicolata dall'omiletica abbia costantemente reagito con il mobilissimo e dinamico spazio di azione della mercatura.
Ľ Ľ Ľ
The merit of dr. Ughetti's thesis lies in having conducted on the concrete level of the sources, in the multi-layered fabric of writing and organisation that shapes and conditions them reciprocally, the analysis of the lexical and conceptual relations that underlie the formation of late medieval economic language.
The refinement of an economic discourse capable of casting light on figures, subjects, actions, contracts to describe and accredit a stable and therefore persuasive image of the European trade partnerships that asserted themselves between the 14th and 16th centuries, finds in this work a point of development, of further maturation of a historiography that by now has a consolidated tradition, dating back at least six decades.
Ughetti's work was recognised by the Scientific Committee awarding the prize as the best among those submitted in this edition, having brought into fruitful dialogue knowledge, textual typologies, but also conceptual codifications that often still remain the prerogative of the study of individual disciplines and chronological partitions that thus reduce the space of their historical understanding.
The close-up analysis of the fourteenth- and fifteenth-century homiletic sources - the pivot of this work - has proven what is their peculiar quality: that of being an intrinsically performative material, constantly socially situated, capable of identifying and defining its civic and economic referent from time to time. It was conducted with profound awareness and attention to the different dimensions of historical research: from philological to full heuristic valorisation. Within this framework, the fruitful cross-fertilisation of the analysis carried out on scriptural, theological, economic and legal dictionaries and languages, including those setting out regulations governing local markets, has given depth and breadth to the research, highlighting the interactions with a long-lasting Christian lexicon. One of the most significant results of this work is worth noting here: the detailed reconstruction of Saint Bernardino's appropriation of the exegesis of Revelation, of its linguistic resources. Detached from its traditionally eschatological and millenarian horizon, it is declined by Albizzeschi in an entirely economic key, acting precisely on the semantic and semiotic expansion of lexemes and key figures of the text. As the scholar himself reminds us, each of the chapters of the doctoral thesis is also proposed as a case study, thus offering itself as a resource and methodological basis for further, evident and fruitful research perspectives.
From the point of view of economic history, this work has the merit of showing how the mendicant homiletic thought, preached, constantly reworked, represented and reported in the contemporary sources reveals the emergence of professional figures, business practices, poverty and wage competitiveness that were identified and measured in their social and political impact, contributing to the construction of that vast range of regulatory devices increasingly necessary for political entities committed to strengthening their solidity through ever-increasing models of centralisation and loyalty. This brought into focus how, with what instruments, in late medieval societies, particularly in France and Italy, the rhetoric conceived and conveyed by homiletics constantly reacted with the highly mobile and dynamic space of action of marketing.
Membri della Giuria del Premio / Members of the Prize Jury:
Guido Alfani (UniversitÓ di Milano), Philippe Bernardi (UniversitÓ di Parigi), Bruno Callegher (UniversitÓ di Trieste), Hilario Casado Alonso (UniversitÓ di Valladolid), Markus A. Denzel (UniversitÓ di Lipsia), Maria Diez Ya˝ez (UniversitÓ Complutense, Madrid), Miriam Davide (UniversitÓ Trieste), Maria Teresa Dolso (UniversitÓ di Padova), Paolo Evangelisti (UniversitÓ di Lleida), Luca Fantacci (UniversitÓ "La Statale", Milano), Riccardo Finozzi (Banca d'Italia), Antoni Furiˇ (UniversitÓ di Valencia), Roberto Lambertini (UniversitÓ di Macerata), Clement Lenoble (CNRS-CIHAM LioneľAvignone), Maryanne Kowaleski (UniversitÓ di Fordham, New York), Angela Orlandi (UniversitÓ di Firenze), Maria Clara Rossi (UniversitÓ di Verona), Petra Schulte (UniversitÓ di Trier), Alessandro Silvestri (UniversitÓ di Salerno), Naresh Singh (UniversitÓ di Ottawa), Lorenzo Tanzini (UniversitÓ di Cagliari), Giacomo Todeschini (ricercatore indipendente).
Segretario Generale del Premio / General Secretary of the Prize: Paolo Evangelisti (UniversitÓ di Lleida).
The refinement of an economic discourse capable of casting light on figures, subjects, actions, contracts to describe and accredit a stable and therefore persuasive image of the European trade partnerships that asserted themselves between the 14th and 16th centuries, finds in this work a point of development, of further maturation of a historiography that by now has a consolidated tradition, dating back at least six decades.
Ughetti's work was recognised by the Scientific Committee awarding the prize as the best among those submitted in this edition, having brought into fruitful dialogue knowledge, textual typologies, but also conceptual codifications that often still remain the prerogative of the study of individual disciplines and chronological partitions that thus reduce the space of their historical understanding.
The close-up analysis of the fourteenth- and fifteenth-century homiletic sources - the pivot of this work - has proven what is their peculiar quality: that of being an intrinsically performative material, constantly socially situated, capable of identifying and defining its civic and economic referent from time to time. It was conducted with profound awareness and attention to the different dimensions of historical research: from philological to full heuristic valorisation. Within this framework, the fruitful cross-fertilisation of the analysis carried out on scriptural, theological, economic and legal dictionaries and languages, including those setting out regulations governing local markets, has given depth and breadth to the research, highlighting the interactions with a long-lasting Christian lexicon. One of the most significant results of this work is worth noting here: the detailed reconstruction of Saint Bernardino's appropriation of the exegesis of Revelation, of its linguistic resources. Detached from its traditionally eschatological and millenarian horizon, it is declined by Albizzeschi in an entirely economic key, acting precisely on the semantic and semiotic expansion of lexemes and key figures of the text. As the scholar himself reminds us, each of the chapters of the doctoral thesis is also proposed as a case study, thus offering itself as a resource and methodological basis for further, evident and fruitful research perspectives.
From the point of view of economic history, this work has the merit of showing how the mendicant homiletic thought, preached, constantly reworked, represented and reported in the contemporary sources reveals the emergence of professional figures, business practices, poverty and wage competitiveness that were identified and measured in their social and political impact, contributing to the construction of that vast range of regulatory devices increasingly necessary for political entities committed to strengthening their solidity through ever-increasing models of centralisation and loyalty. This brought into focus how, with what instruments, in late medieval societies, particularly in France and Italy, the rhetoric conceived and conveyed by homiletics constantly reacted with the highly mobile and dynamic space of action of marketing.
Membri della Giuria del Premio / Members of the Prize Jury:
Guido Alfani (UniversitÓ di Milano), Philippe Bernardi (UniversitÓ di Parigi), Bruno Callegher (UniversitÓ di Trieste), Hilario Casado Alonso (UniversitÓ di Valladolid), Markus A. Denzel (UniversitÓ di Lipsia), Maria Diez Ya˝ez (UniversitÓ Complutense, Madrid), Miriam Davide (UniversitÓ Trieste), Maria Teresa Dolso (UniversitÓ di Padova), Paolo Evangelisti (UniversitÓ di Lleida), Luca Fantacci (UniversitÓ "La Statale", Milano), Riccardo Finozzi (Banca d'Italia), Antoni Furiˇ (UniversitÓ di Valencia), Roberto Lambertini (UniversitÓ di Macerata), Clement Lenoble (CNRS-CIHAM LioneľAvignone), Maryanne Kowaleski (UniversitÓ di Fordham, New York), Angela Orlandi (UniversitÓ di Firenze), Maria Clara Rossi (UniversitÓ di Verona), Petra Schulte (UniversitÓ di Trier), Alessandro Silvestri (UniversitÓ di Salerno), Naresh Singh (UniversitÓ di Ottawa), Lorenzo Tanzini (UniversitÓ di Cagliari), Giacomo Todeschini (ricercatore indipendente).
Segretario Generale del Premio / General Secretary of the Prize: Paolo Evangelisti (UniversitÓ di Lleida).